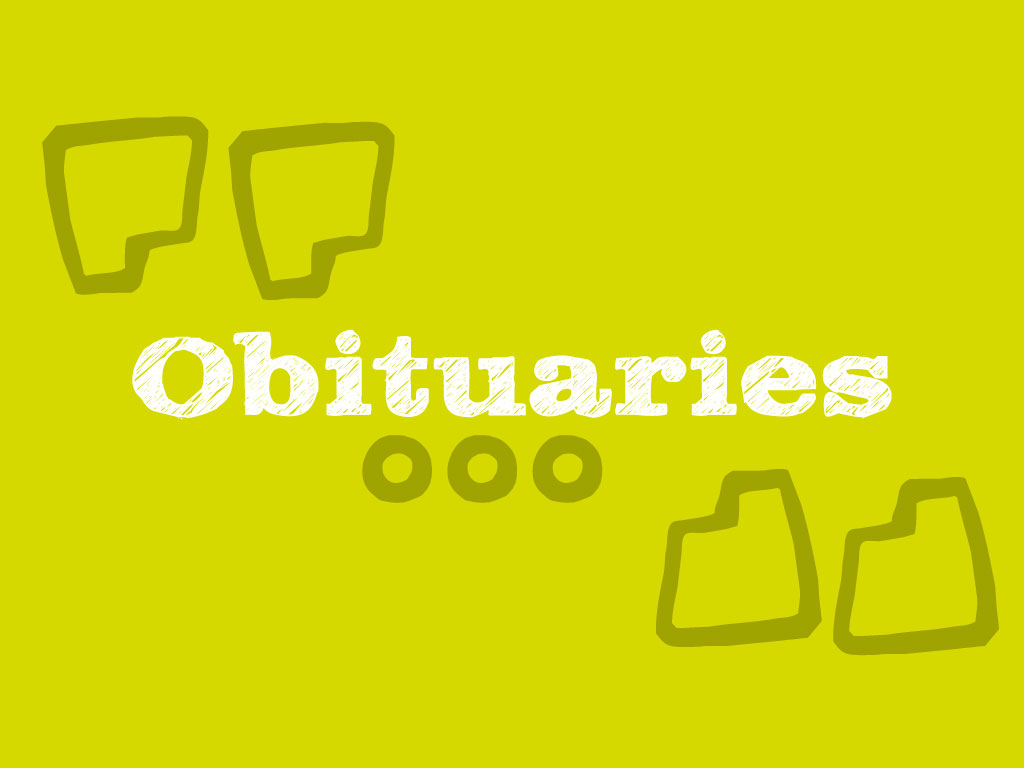di Marco Pannella
Noi radicali abbiamo anticipato molte delle cose che papa Francesco dice e fa. La sua religiosità, così vicina alle persone semplici e vere, è molto vicina anche alle mie origini. È il terzo Pontefice con cui ho buoni rapporti. Giovanni Paolo II, il “polaccone” come lo chiamavo io, lo sentivo spesso. Quanto a Ratzinger, beh, sapevo che ci avrebbe stupito. Io sono anticlericale, è vero. Sulle cose concrete, però, il mio spirito è religioso. Ho sempre avuto rapporti splendidi con le suore. Mio zio, poi, era sacerdote e sono cresciuto con quei sentimenti, con quei valori. Sono un orso abruzzese, da piccolo assistevo a tutte le processioni di paese, con le donne che salivano sulla montagna salmodiando. E quel mio zio sacerdote era un liberale, un talent scout, aveva una rivista alla quale collaboravano Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Croce mi volle conoscere e, da quel momento, la sua famiglia matriarcale mi è sempre stata accanto (1). Il massimo di pubbliche responsabilità che nella mia vita ho ricoperto – università a parte – sono stati cento giorni da Presidente della Circoscrizione di Ostia. Per il resto, non sono nemmeno semplice Cavaliere della Repubblica, e resto soldato semplice da 57 anni, in congedo nemmeno come caporale. Sono nullatenente. Da poco, ma lo sono! Da decenni vivo come e perché questa mia vita da radicale mi colma, m’appassiona, e riconosco nella gente comune la stessa mia cifra di persona comune (2)…
C’è per esempio, il pluri-ergastolano Piromalli, “capo” di una “famiglia” nota come appartenente alla ‘ndrangheta…È in cattive condizioni di salute, è sottoposto a trattamenti carcerari molto duri e qualche volta – lo confesso – incomprensibili o intollerabili. Perché mai, dunque, Piromalli si è iscritto al Partito Radicale? Ed ha versato due volte, le 150mila lire dell’iscrizione minima? Per finanziarci? Per essere liberato? Per essere eletto deputato? Perché abbiamo programmi criminali e di sostegno al crimine? Strano: “il padrino” ha avuto successo perché ha cercato di tratteggiare, scoprire qualche tipo di umanità che potesse spiegare il carisma di grandi boss, di feroci criminali. La complessità, la “ricchezza” di una persona, la sua “diversità” piuttosto che la sua “perversità”, le radici antropologiche e culturali niente affatto estranee all’umanità di tutti, ahinoi! è apparsa in qualche misura come evidentemente, plausibile, tanto più pericolosa, penso, quanto meno attribuibile a “nature demoniache”. Penso piuttosto che proprio Piromalli, non quello “trionfante” libero e potente, ma quello sconfitto e ormai inerme abbia voluto essere “anche” radicale, “anche” nonviolento, lasciare magari ai suoi nipoti, a chi comunque crede, ha creduto in lui, questo segnale. Sta di fatto che egli ha voluto concorrere a “salvare” il PR. Se avesse avuto ancora da conquistare, contrattare, salvare “potere”, allora avrebbe avuto contatti con tutti, tranne che con noi. E dico proprio “tutti”. Ma il problema vero non è questo. Il nostro Statuto è quello di un partito-servizio pubblico. Chi vuole, paga il biglietto e viaggia, per un anno, verso dove la diligenza si dirige. E dove si dirige, di volta in volta, lo stabilisce il Congresso, e chi fra di noi ha responsabilità ufficiali o sostanziali di guida del Partito. Certo, in questo modo il trasporto è promiscuo, come lo erano le carovane del West, di John Ford. Spesso organizzate da quacqueri, da puritani, per recarsi a vivere nei “pascoli del cielo” della purezza, dell’onestà, del lavoro, e della pace, ma poi composte anche da “cattivi”. I quali, non di rado, salvano proprio loro gli inermi, a spese della loro vita… (3)…
Spes contra spem (4), essere speranza, non limitarsi ad averla. Questo mi auguravo, e ho sperato che papa Francesco avesse questo punto di riferimento. L’invito a essere misericordiosi…per carità, a livello teologico e via dicendo sicuramente può essere anche di affascinante interesse; ma a livello lessicale, a livello di vita, credo si debba dire quello che cerco di dire quando vado in visita nelle carceri. Guardate, che la disperazione di tutti voi che vivete nelle carceri (e dunque non solo i detenuti, ma anche le loro famiglie, la polizia penitenziaria, i volontari e tutti coloro che lavorano lì), a tutta quella comunità dico e ripeto sempre una sola cosa: non cedete alla disperazione, non siate rassegnati, voi siete speranza, per coloro che vi amano e che amate. Se non comprendete questo, e vi lasciate andare alla di-speranza, alla di-sperazione, colpite proprio coloro che vi amano: coloro per i quali voi siete speranza. È questo che dico ai detenuti, ogni volta che li incontro; ed è questo che mi auguravo dicesse papa Francesco durante questo anno santo appena proclamato. Così avrebbe parlato al mondo intero, anche ai credenti in altro che nel magistero della Chiesa, e credo sarebbe stato enormemente efficace. Questo invito a essere misericordiosi, c’è sempre nell’insegnamento e nella vita della Chiesa e dunque non comprendo lo specifico di questo momento. Si dice che questo sia un momento particolarmente infelice e cattivo, e proprio in questo momento c’è bisogno di misericordia. Io sono convinto che proprio in questo momento ci sia bisogno di essere speranza, di diventarlo; di rendersi conto che se non lo si fa, facciamo disperare coloro che sperano in noi, coloro che ci amano, coloro che amiamo; con questa scelta di indicare la misericordia, in termine di lessico, di linguaggio credo non si riesca a parlare efficacemente proprio di quello di cui papa Francesco sicuramente vuole parlare, in Italia, a Cuba, in America Latina, ovunque (5)…
Io amo gli obiettori, i fuori-legge del matrimonio, i capelloni sottoproletari anfetaminizzati, i cecoslovacchi della primavera, i nonviolenti, i libertari, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, i borghesi come me, la gente con il suo intelligente qualunquismo e la sua triste disperazione. Amo speranze antiche, come la donna e l’uomo; ideali politici vecchi quanto il secolo dei lumi, la rivoluzione borghese, i canti anarchici e il pensiero della Destra storica. Sono contro ogni bomba, ogni esercito, ogni fucile, ogni ragione di rafforzamento, anche solo contingente, dello Stato di qualsiasi tipo, contro ogni sacrificio, morte o assassinio, soprattutto se “rivoluzionario”. Credo alla parola che si ascolta e che si dice, ai racconti che ci si fa in cucina, a letto, per le strade, al lavoro, quando si vuol essere onesti ed essere davvero capiti (6)…
Dobbiamo prendere atto che potendolo, rispetto a tutti quelli che lo potevano, solo papa Francesco ha riproposto quanto già l’ex presidente Giorgio Napolitano aveva formalmente chiesto alle istituzioni, che però sono rimaste sorde. Evviva papa Francesco. Stavo per chiedergli di essere coraggioso, ma avevo un po’ di pudore; invece, è arrivata la sua perorazione e quindi domanderò di essere ricevuto in Vaticano per ringraziarlo. Il Papa ha avuto il coraggio e quando il coraggio si esprime per dare forza alla legge che invece viene umiliata, negata da coloro che hanno la funzione di farla vivere, è davvero un gran bel momento. Questa amnistia è una speranza per tanti a cui va ridata una speranza (7)…
Se pensiamo a un’opinione pubblica vasta, che non sempre ha modo di leggere le cose in profondità, dovrei tener presente anche questo aspetto, che si dica: “vedete Pannella come applaude il Papa, si è convertito”. Eppure, io credo che molti diranno altro, penseranno “Vedi sto pazzo di Papa, s’è convertito lui”. Nel momento in cui lui sceglie un tema come quello dell’amnistia, sa benissimo di schierarsi in una battaglia assolutamente politica su un terreno che è tipicamente quello di noi radicali (8)…
Temo che l’indifferenza dello Stato accentui la disperazione delle donne e degli uomini ammassati nelle prigioni. Corpi a cui viene tolta la dignità, vengono annullati i diritti fondamentali e per i quali il principio della Costituzione secondo cui la pena deve tendere al reinserimento sociale si rivela una beffarda irrisione. La tracotanza di chi ha la responsabilità di questo stato di cose sembra affidarsi alla sicurezza che in carcere si continuerà a subire in silenzio, a morire, a suicidarsi, e che non ci saranno rivolte violente e che il sangue che scorrerà sarà solo quello delle vittime senza voce. Hanno rinchiuso nelle gabbie migliaia e migliaia di soggetti deboli, poveri, stranieri, tossicodipendenti, emarginati, border line, trasformando il carcere in una discarica sociale e malignamente si accaniscono secondo la massima vigliacca: forti con i deboli, deboli con i forti. I garanti dei diritti dei detenuti in tante città hanno presentato una piattaforma delle “cose da fare subito” riprendendo una felice espressione di Ernesto Rossi del 1949. Io non mi rassegno al fatto che tante buone volontà vengono bistrattate. Immagino perciò un digiuno ad oltranza, fino all’ultimo giorno della legislatura. Una catena nonviolenta e di massa, una mobilitazione collettiva per un obiettivo puntuale: un decreto-legge contro gli effetti delle leggi emergenziali e classiste. Io facevo parte della delegazione dei firmatari della lettera aperta scritta dal professor Pugiotto in cui si chiedeva al Presidente della Repubblica di inviare un messaggio alle Camere per una assunzione di responsabilità sulla questione del carcere e in quella occasione feci presente che il sovraffollamento non era un accidente ma aveva una causa nelle leggi criminogene e in particolare nella legge sulle droghe. Per rispondere alla “prepotente urgenza” il governo aveva una sola strada, quella del decreto-legge per cancellare le norme più nefaste della legge Giovanardi che causano l’ingresso in carcere di oltre ventimila consumatori (e piccoli spacciatori) di sostanze stupefacenti e di 24mila tossicodipendenti, vittime della legge Cirielli sulla recidiva. Nel 2006 con un colpo di mano istituzionale e contro la prescrizione costituzionale del carattere di necessità e urgenza, la riforma proibizionista e punitiva della legge sulla droga fu inserita nel decreto-legge delle Olimpiadi invernali. Oggi di fronte allo spaventoso sovraffollamento delle carceri (metà dei detenuti per fatti relativi a quella legge) vi sono tutte le ragioni politiche e costituzionali per un decreto che incida sui fatti di lieve entità relativi alla detenzione di sostanze stupefacenti e modifichi gli articoli che impediscono la concessione di misure alternative ai tossicodipendenti (9)…
Il vero problema che stiamo vivendo è che da molti decenni abbiamo uno stato italiano nelle mani dell’influenza di un regime. Io ritengo che noi oggi ci troviamo nelle condizioni simili a quelle degli anni tremendi della storia umana, che manifestamente veda costituire i poteri decisionali dello Stato italiano quasi sempre in sintonia con gli editti di un regime che è tutto dalla parte del non rispetto dei diritti umani, del non rispetto dei diritti vigenti all’ONU e nell’UE, e in teoria anche nello Stato italiano… C’è la vigenza non dello stato di diritto ma di uno stato d’emergenza. Questo regime, non questo Stato, e noi siamo dalla parte dello Stato per cercare di aiutarlo nel compiere le difficili scelte di chi tenta di richiamare il problema del rispetto delle leggi che dovrebbero essere vigenti e sono vigenti tecnicamente, ma annullate semplicemente a livello pratico. Il sistema giustizia è arrivato a livelli di assoluta contro produttività con drammatici riflessi sul sistema Paese nel suo complesso, che pregiudicano investimenti e condizioni del vivere civile. Alla fine, la situazione peggiora giorno dopo giorno; come, giorno dopo giorno, peggiora lo stato della democrazia italiana, che viola le proprie leggi ed i patti internazionali, tentando di coprire invano le proprie vergogne con la foglia di fico dei proclami ad effetto che dichiarano giustizia per tutti ma la garantiscono solo per qualcuno (10)…
Sosteniamo, insieme, che non esistono nelle carceri, negli ospedali, nei manicomi, nelle strade, sui marciapiedi, nei tuguri, nelle bidonville, dei “peggiori”, ma anche lì, dei “diversi” malgrado la miseria (che è terribile proprio perché degrada, muta, fa degenerare: e se no, perché la combatteremmo tanto?), malgrado il lavoro che aliena (che rende “pazzi”), malgrado che lo sfruttamento classista sia “secolare”, quindi incida sull’ereditarietà. Sogniamo – e v’è rigore e responsabilità nei nostri sogni – una società senza violenza e aggressività o in cui, almeno, deperiscano anziché ingigantirsi e esservi prodotte. Sosteniamo che è morale quel che tale appare a ciascuno. Lottiamo contro una “giustizia” istituzionale (e “popolare”) che ovunque scambia diversità per perversione, dissenso per peccato. Come possiamo, allora, recuperare proprio in politica, nella vita di ogni giorno nella città, il concetto di “male” di “demonio”, di “perversione”? Così abbiamo palato, come abbiamo potuto e dovuto, con i piedi, nelle marce, con i sederi, nei sit-in, con gli happening continui, con erba o con digiuni, obiezioni che sembravano “individuali” e “azioni dirette” di pochi, in carcere o in tribunale, con musica o con comizi, ogni volta rischiando tutto, controcorrente sapendo che un solo momento di sosta ci avrebbe portato indietro di ore di nuoto difficile, troppo spesso considerati “diversi” dai compagni e colmi invece d’attenzioni continue, di provocazioni, di colpi da parte dei pula e non dei minori. Abbiamo durato, rifiutando di sopravvivere, ricominciando sempre, facendo anche delle sconfitte materia buona per far volto e corpo alle nostre testarde ed alla fine semplici e antiche speranze (11).
L’indifferenza e l’inerzia sono i nostri nemici. Nel pieno degli anni di sangue e di piombo, consentiti se non commissionati direttamente dai palazzi del potere reale che usurpa quello legale e costituzionale del nostro paese, il Partito Radicale non perdeva occasione per intervenire contro la violenza e le violenze dei “compagni assassini”. Affermavano che “violenti” e “nonviolenti” erano fratelli, tragicamente separati, ed estranei. Insieme sapevamo che occorre dar non solamente parola, ma anche mano, corpo – nell’oggi – alle speranze e agli ideali; concepire un nuovo possibile contro il possibile ormai logoro e terribile che si sta consumando. Ma in loro, nei compagni e fratelli assassini, e suicidi, mancava la convinzione che occorra prefigurare nell’oggi il domani, che “dar corpo” alle idee di giustizia, di pace e di libertà, non basta: occorre dare il proprio corpo; e darlo alla felicità, alla tolleranza, al dialogo, alla gente e al diritto, alla drammatica pienezza e al rigore della fantasia ragionevole e buona (12).
1) Notizie Radicali, 15 maggio 2015.
2) Dalla pagina Facebook di Marco Pannella.
3) Il Resto del Carlino, 10 gennaio 1987.
4) Citazione dalla traduzione in latino della Lettera di San Paolo ai Romani, 4.18.
5) Notizie Radicali, 14 aprile 2015.
6) Dalla prefazione di Marco Pannella al libro di Andrea Valcarenghi, Underground a pugno chiuso.
7) Italia Oggi, 6 settembre 2015.
8) Il Garantista, 4 settembre 2015.
9) Il Manifesto, 23 ottobre 2012.
10) Faro di Roma, 1 febbraio 2016.
11) Dalla prefazione di Marco Pannella al libro di Andrea Valcarenghi, Underground a pugno chiuso.
12) Notizie Radicali, 1 dicembre 1986
di Francesco Petrelli*
Nel sintagma programmatico originale del governo si diceva: “garantisti nel processo e giustizialisti nell’esecuzione”. Un tentativo di mettere insieme due realtà che non sono in alcun modo conciliabili, né sotto il profilo giuridico né logico, perché l’assunto garantista trova il proprio fondamento nel riconoscimento della dignità dell’uomo che è un valore che non può che prescindere dall’accertamento delle sue eventuali responsabilità penali. Garantismo e giustizialismo non possono essere “due rami dello stesso albero”. Si deve necessariamente scegliere da che parte stare.
D’altronde questa tensione irrisolta è piuttosto evidente all’interno della maggioranza di governo. Anche se per ovvi motivi essa tende ad una apparente ricomposizione. Ma la questione oltre che politica è culturale e certe posizioni sono inevitabilmente destinate a cadere. Stando all’assunto giustizialista “in purezza” si sarebbe dovuto innanzitutto riformare l’art. 27 Cost. riconducendolo al solo paradigma retributivo, ed abrogare poi anche l’istituto della revisione, evidentemente contrario al “marcire in galera” del reo.
Ora, invece, nessuno nega pubblicamente la finalità rieducativa della pena e certe velleità “ideologiche” sono state accantonate. La verità è che le garanzie, una volta date come coessenziali al sistema, permangono ostinatamente anche oltre i confini del giudicato ove sono presenti ampi spazi di tutela in favore del condannato. Nessuna forza politica che voglia proporsi come responsabile forza di governo può rinnegare questa verità. L’avere accertato le responsabilità penali di un imputato non annulla certo la dignità della sua persona e non cancella i suoi diritti.
Al di là dagli slogan giustizialisti, all’interno di alcuni settori della maggioranza di governo queste verità autoevidenti hanno trovato inevitabilmente spazio, ma le parole d’ordine della “certezza della pena”, declinata in chiave securitaria, e le posture inflessibili della “resa dello Stato” hanno fino ad ora impedito ogni minimo provvedimento deflattivo. Anche la liberazione anticipata speciale che, nelle drammatiche condizioni date, non ha nulla di premiale – prospettandosi solo come un minimo risarcimento per l’afflittività di una pena resa doppia dai modi in cui viene espiata – ha subito un radicale rifiuto. Ma si tratta di una dimostrazione di debolezza. Insistere su questa strada non ha probabilmente alcuna convenienza per chi la percorre.
Vi è una ostinazione tutta propagandistica in base alla quale la pena deve equivalere al carcere, senza avvedersi che un’ottica simile ci fa arretrare di almeno cento anni indietro in quanto oggi nessuno immagina più delle pene detentive che non siano elastiche e come tali suscettibili di modulazioni differenti, dalla probation alla liberazione anticipata riconosciuta in base alla buona condotta.
Quell’ennesimo suicidio dell’agente di custodia consumato sulle mura di cinta del carcere palermitano dell’Ucciardone, le rivolte disperate, che stanno esplodendo senza scopo e senza senso nelle carceri italiane, sono tutti eventi che danno un senso ancor più drammatico, se possibile, ai sessantatré suicidi di detenuti. Eventi che hanno tutti probabilmente motivazioni assai diverse che andrebbero studiate e analizzate, ma che certamente illuminano la realtà del carcere come fosse un luogo surreale, un pozzo oscuro e profondo di incomprensioni, di luoghi comuni e di coazioni a ripetere.
La verità è che il carcere è un problema, mentre ci si ostina a considerarlo come una soluzione. Occorrerebbe istituire un nuovo Ministero. Un ministero per la Riforma del carcere che funzionasse come permanente luogo di studio di quel problema. Si continua invece a pensare al carcere come una risorsa in sé sulla quale investire. Un bene da incrementare.
Si modificano le misure alternative già esistenti, si provvede a catalogare strutture per tossicodipendenti non esistenti. Non si rimuovono i motivi delle rivolte, ma si organizzano nuovi reparti speciali per sedare le rivolte, a riprova della opportunità di introdurre il reato di rivolta.
Infine, l’idea resta quella di costruire nuove carceri. Carceri come quelle già esistenti. Carceri nuove come quelle di più recente costruzione, nelle quali comunque ci si suicida. Carceri come quelle vecchie ma che saranno chiamate comunque nuove. Carceri intese ancora una volta come contenitori. Commissari per costruire carceri come contenitori di uomini. Non si sa bene perché costruirle, né come saranno costruite, mentre dovrebbe cambiare il perché costruirne e conseguentemente dovrebbe cambiare il come.
Spesso gli slogan e le parole d’ordine sono efficaci veicoli di consenso, ma divengono ostacoli sulla via della ragionevolezza. Si trasformano in gabbie che impediscono di agire adeguandosi alla necessità, alle condizioni mutate, all’imprevedibile svilupparsi degli eventi. Poiché si tratta di slogan se ne dovrebbe riconoscere la capacità evolutiva. Ma la strada da percorrere mi pare ancora lunga e per certi versi misteriosa, perché non sappiamo quali nuove proposte possano ancora prendere corpo. Gli slogan sono pericolosi perché sono gabbie, ma sono al tempo stesso anche strutture fragili destinate ad imprevedibili “dissolvenze incrociate”: “certezza della pena” può anche significare “certezza che le pene abbiano raggiunto il loro scopo rieducativo” comunque esse siano immaginate.
*Presidente Unione Camere Penali Italiane.
di Michele Minorita
Chi volesse realizzare una rassegna/retrospettiva dedicata al carcere non avrebbe che l’imbarazzo della scelta, e certamente dovrebbe avere a disposizione molti giorni. La realtà carceraria è stata affrontata in tanti modi: abbiamo a disposizione film drammatici e d’avventura, perfino di fantascienza. C’è il filone della pena di morte, della fuga e dell’evasione, delle condizioni negli istituti di pena. Se ne può citare qualcuno: Le ali della libertà (1994), di Frank Darabont: Shawshank è un penitenziario in cui Andy Dufresne (Tim Robbins), mite vicedirettore di banca, viene incarcerato dopo essere stato ingiustamente condannato a due ergastoli per l’omicidio della moglie e del suo amante. In carcere Andy deve sopportare la violenza gratuita di secondini e detenuti ma riesce a sopravvivere e con l’aiuto Red, un altro ergastolano (Morgan Freeman), realizza un’incredibile evasione.
Il miglio verde, (1999), anche questo diretto da Darabont. Paul Edgecombe (Tom Hanks) racconta ad una amica di quando in gioventù lavorava come secondino nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, chiamato il miglio verde per il colore del pavimento percorso dai condannati. Edgecombe ricorda l›arrivo di John Coffey, un gigantesco detenuto di colore apparentemente ritardato, accusato dello stupro e dell’omicidio di due bambine: col Paul si rende conto che Coffey non è quello che sembra, scopre un incredibile segreto che gli cambia la vita.
Hunger (2008), film d’esordio alla regia di Steve McQueen: racconta la detenzione del militante dell’IRA Bobby Sands (Michael Fassbender) e i soprusi che i detenuti subiscono da parte delle guardie. Bobby e altri attivisti intraprenderanno diversi scioperi della fame, come protesta al trattamento subito e per ottenere lo status di prigionieri politici; per quello sciopero della fame moriranno.
Fuga di mezzanotte (1978), di Alan Parker: biografia di Billy Heyes, incarcerato per anni a Sagmalcilar in Turchia. Billy (Brad Davis) viene arrestato ad Istambul, dove si trova in vacanza con la fidanzata, per detenzione di 2kg di hashish. Condannato a trent’anni di detenzione, subisce terribili supplizi da parte delle guardie.
Nel nome del padre (1993), di Jim Sheridan, dal romanzo autobiografico Il prezzo dell’innocenza, di Gerry Conlon: è il racconto di come lui e i suoi famigliari vengono ingiustamente accusati di un attentato: il 10 ottobre 1974 l’IRA fa esplodere un ordigno in un pub di Guildford, uccidono sette persone: della strage sono accusati senza prove Conlon (Daniel Day-Lewis), il padre e altri famigliari. Solo dopo molti anni di reclusione, superando soprusi e sofferenze, viene provata la loro innocenza.
Il profeta (20099, di Jaques Audiard: il diciannovenne Malik El Djebena (Tahar Rahim) deve scontare una pena di sei anni di carcere; fragile, analfabeta, in carcere Malik cambia completamente: impara a leggere e a scrivere, viene protetto di un boss della mafia còrsa che lo inserisce nei traffici della criminalità organizzata. Costretto a collaborare contro la sua volontà, il giovane si ribella.
Dead Man Walking (1995), di Tim Robbins, interpretato da Susan Sarandon e Sean Penn. Matthew Poncelet si trova nel braccio della morte per aver massacrato, insieme ad un complice a cui però è stato dato solo l’ergastolo, una coppia di fidanzati. Il giovane si dichiara innocente ma non riesce ad ottenere la grazia; scrive quindi ad una suora, Helen Prejean, per chiedere conforto e assistenza. Suor Helen si prende a cuore il caso, decisa ad ottenere giustizia.
Leonora (2008), di Pablo Trapero. Racconta la durezza della vita in un carcere argentino per le donne incinte e le giovani madri, costrette a crescere i figli in condizioni difficili. Julia, incinta, è accusata per un crimine che non ricorda di aver commesso. Dà alla luce Tomás e deve combattere una lunga battaglia per mantenerne la custodia.
L’uomo di Alcatraz (1962), di John Frankenheimer, con Burt Lancaster. Una vera storia di prigionia: quella di Robert Stroud, condannato all’ergastolo. Durante gli anni di isolamento, Robert si dedica all’ornitologia, diventa uno dei più grandi esperti al mondo sull’argomento; scrive poi un trattato sulle terribili condizioni di detenzione. La sua opera viene notata da un giornalista che scrive un libro su di lui, e porta il suo caso l’attenzione dei media.
Brubaker (19809, di Stuart Rosemberg; si ispira alla storia di Thomas Murton, criminologo che negli anni ’60 viene incaricato di riformare il sistema carcerario dell’Arkansas. Henry Brubaker (Robert Redford), criminologo ed ex capitano dell’esercito, diventa il nuovo direttore del penitenziario di Wakefield, dove i detenuti subiscono soprusi e violenze di ogni genere. Brubaker per un certo periodo si finge detenuto, per verificare di persona. Quando cerca di migliorare le condizioni di vita all’interno del carcere, si scontra con l’ingiustizia di un sistema corrotto.
Scum (1979), di Alan Clarke è incentrato sulla brutalità dei riformatori britannici negli anni ’70. Il protagonista è Carlin, trasferito in un durissimo riformatorio dopo aver aggredito una guardia: col tempo il ragazzo si trasforma in un vero e proprio boss che con la violenza e la corruzione delle guardie detta legge all’interno del carcere.
Per quel che riguarda le pellicole italiane non si può non citare Detenuto in attesa di giudizio, di Nanni Loy (1971). È la storia di un geometra, Giuseppe Di Noi, da anni trasferitosi in Svezia. Decide di venire in vacanza in Italia con la famiglia. Alla frontiera Di Noi, senza alcuna spiegazione, lo arrestano, e comincia la sua Odissea. Sballottato da un carcere all’altro, solo dopo molto tempo apprende di essere accusato dell’omicidio colposo preterintenzionale di un cittadino tedesco. Di Noi (interpretato da uno straordinario Alberto Sordi) patisce un lungo calvario, costellato da trattamenti umilianti, un incubo che si consuma per mesi. Il magistrato inquirente sostiene di non poterlo interrogare perché non ha nominato un avvocato difensore; Di Noi si trova coinvolto in una rivolta carceraria, scampa a stento a una violenza, si trova poi rinchiuso in una struttura psichiatrica. Solo per l’ostinazione della moglie riesce a uscire dall’incubo. Viene dimostrata l’infondatezza dell’accusa: il tedesco è morto per il crollo accidentale del viadotto che percorreva, e finalmente disposta la scarcerazione, ma Di Noi uscirà da questa esperienza irrimediabilmente traumatizzato: pur prosciolto e rilasciato, Di Noi è ormai mentalmente distrutto. Per questa sua interpretazione Sordi vince l’Orso d’argento al Festival di Berlino. L’ispirazione per il film viene allo stesso Sordi dopo aver letto il libro di Lelio Luttazzi Operazione Montecristo. Un’altra fonte di ispirazione è l’inchiesta per la RAI Verso il carcere, di Emilio Sanna. Il film suscita un grande scalpore: per la prima volta si denuncia l’arretratezza e la drammatica inadeguatezza del sistema giudiziario e carcerario italiano.
Altri film sull’argomento:
Ariaferma, di Leonardo Di Costanzo. Racconta i giorni “senza tempo” in un carcere in via di dismissione. Il regista specifica che non è “un film sulle condizioni delle carceri italiane, ma sull’assurdità del carcere”. Toni Servillo interpreta l’ispettore Gaetano Gargiulo: deve sorvegliare i detenuti nei giorni della transizione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti restano in attesa di conoscere quale sia la loro destinazione. Ariaferma, spiega Servillo, “non deve essere appiattito solo sul tema delle carceri, offre spunti di riflessione anche a chi in carcere non è”.
Grazie ragazzi, di Riccardo Milani racconta, in modo brillante ma non superficiale, di come l’esperienza del teatro possa diventare un’occasione di confronto e riscatto per chi è detenuto. Milani lo ha sperimentato direttamente: “Mi è capitato di lavorare all’interno delle carceri a Sulmona, Regina Coeli e Rebibbia. Alla base del film c’è una storia vera, accaduta in Svezia negli anni ’80, trasferita sul grande schermo dal regista francese Emmanuel Courcol con il film ‘Un triomphe’”.
Sulla mia pelle, di Alessio Cremonini. Ha fatto molto discutere. Racconta la morte di Stefano Cucchi. Ricostruisce l’ultima settimana di vita di Stefano: arrestato per detenzione di stupefacenti, viene malmenato con inaudita violenza dai carabinieri. Portato in carcere, per l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche già precarie, è trasportato d’urgenza in ospedale dove muore, senza neppure poter rivedere i genitori e la sorella Ilaria.
La seconda vita, di Vito Palmieri, è la storia di Anna: un giorno appare in una tranquilla e sonnolenta città di provincia. Fa la bibliotecaria, nessuno sa che alle sue spalle ci sono otto anni di carcere per un reato commesso da adolescente per cui lei ha abbondantemente pagato; Marianna Fontana è la brava protagonista, capace di dare al personaggio che interpreta in giusto mix di durezza e dolcezza. Anna riscopre la bellezza della quotidianità, del lavoro; c’è anche il timido e struggente amore di Antonio. Ma al proprio passato non si sfugge, e la provincia si rivela un coacervo di pubbliche, ostentate virtù, e meschini, ipocriti perbenismi. Il tema de La seconda vita è quello della giustizia riparativa e del reintegro sociale.
di Emilio Sanna*
Nel 1969 lavoravo a Roma ai programmi culturali televisivi della Rai. Mi fu affidata un’inchiesta sulle carceri in Italia. Non credevo alle mie orecchie. Nella mappa degli argomenti italiani di quegli anni, il penitenziario appariva con il classico: hic sunt leones. Un vero tabù. Mi recai da Guido Gonnella, allora ministro di Grazia e Giustizia. Mi accolse con molto garbo. Dopo un colloquio di quarto d’ora mi aprì le porte dell’universo carcerario italiano.
L’inchiesta in tre puntate, dal titolo Dentro il carcere, fu trasmessa nel gennaio 1970 dalla seconda rete (oggi Raidue). Poco dopo l’editore De Donato pubblicò un mio libro, Inchiesta sulle carceri. La trasmissione e il libro suscitarono un tale vespaio che ritenni opportuno rendermi irreperibile, rifugiandomi a Nesso, sul lago di Como.
Qui mi raggiunse la telefonata di Alberto Sordi. Ignoro come mi abbia scoperto. Voleva fare un film sulle carceri in Italia. Ero sbigottito. Cosa ne avrebbe fatto Sordi? Dalla tragedia alla farsa? Lui attore comico per antonomasia mutato in tragico? Il dubbio mi rimase dopo un incontro a casa di Vittorio De Sica, dapprima candidato alla regia, e dopo i cento pomeriggi passati da Sergio Amidei a scrivere la sceneggiatura con Dante Troisi. Non ho mai incontrato Sordi. Per vedere il film, ho dovuto attendere l’anteprima di Detenuto in attesa di giudizio. Il dubbio si è sciolto.
È un Sordi tragicomico come i veri grandi attori. Capace di rovesciare come un guanto lo stereotipo dell’italiano furbastro, becero, mammone. Qui è l’altro italiano, onesto, laborioso, rispettoso delle leggi, che si ritrova preso improvvisamente dagli ingranaggi della giustizia e stritolato. È l’italiano vittima delle procedure, delle prepotenze, delle leggi applicate con ottuso rigore. È l’italiano suddito coartato nella sua crisalide incapace di uscire farfalla-cittadino.
Cito Morando Morandini: “Sordi si mette al servizio della storia e dei suoi intenti come non ha fatto spesso nella sua lunga carriera. Nato dalla paura Detenuto in attesa di giudizio è un film che mette paura. Anche oggi”.
*sceneggiatore di Detenuto in attesa di giudizio.
di Maria Antonietta Farina Coscioni
La domanda cui rispondere è questa: la legge deve proteggere, come valore assoluto e incondizionato la mera sopravvivenza biologica, anche quando questa sopravvivenza priva l’uomo della sua dignità, ne mortifica la volontà, ne umilia il corpo e l’esistere diventa un sacrificio e un dolore? La risposta non sarà la navicella Sarco: “La pistola fumante”, per così dire, del suicidio assistito di questi giorni di una americana. Se c’è una veste che inizia a starmi stretta è proprio l’evocare da parte dei media, del suicidio assistito come unica scelta consapevole e informata per il trapasso a miglior vita.
Anche il dibattito in Senato è asfissiante. Lo è per un’unica ragione: per come sono stati redatti i disegni di legge, meglio nessuna legge sulla morte assistita. Se ne convincano i malati pronti per partire in Svizzera e gli accompagnatori al seguito con o senza la navicella, niente affatto “spaziale” Sarco. “Quando ho saputo in quali condizioni Luca (Coscioni) riusciva a comunicare col mondo esterno non ho potuto fare a meno di pensare a come doveva essere il suo mondo interiore. Ho provato un enorme rispetto per questo uomo eroico che perseguiva un obiettivo davanti al quale la maggioranza di noi si sarebbe lasciata andare. Luca è uno dei rarissimi casi in cui la natura umana, tanto e giustamente criticata nelle sue molteplici manifestazioni negative, si erge ad altezze che giudicheremo irraggiungibili. Se l’essere umano può essere questo allora vi sono ancora speranze per la sgraziata specie alla quale apparteniamo”.
Così José Saramago si rivolse a Luca, ucciso dalla SLA a 38 anni. Quando parliamo di morte, pensiamo a malattie come questa. È democratica: colpisce le persone indipendentemente dal sesso, dall’etnia, dallo stato sociale o economico. Non teme nazionalità o confini. E prima di morire, lasciamole libere, di provare dignitosamente a vivere.
di Rav Riccardo Di Segni
È successo a tutti in questi mesi. Stiamo seduti davanti alla televisione accesa e sentiamo l’ennesima notizia o commento pieni di odio e disinformazione contro Israele. Possiamo reagire con la rabbia, con l’insulto diretto a chi parla, scrivere su Facebook, protestare con il direttore di testata, o rinchiuderci nell’apatia. Tutte reazioni comprensibili. Ma questo basta? Siamo sicuri che il nostro essere ebrei non ci richieda anche qualcos’altro, su un piano differente?
La tragedia del 7 ottobre e la guerra che ne è derivata hanno determinato reazioni in tutto il mondo e soprattutto nella comunità ebraica. Nella maggioranza dei casi si è trattato e continua ad essere un coinvolgimento politico con un’intensa partecipazione emozionale, quale che sia la posizione che si assume, dal sostegno totale e incondizionato alla critica. C’è un aspetto della reazione che, a confronto con gli altri prevalenti, è passato sotto tono, quasi relegato per molti alla sfera privata o di piccoli gruppi: la dimensione spirituale, o meglio religiosa. È la domanda, davanti a tutto quello che è successo e continua a succedere, se vi sia un senso, un messaggio dall’alto, una sollecitazione a interrogare le coscienze, una spiegazione nelle fonti antiche, una guida per uscirne fuori. Se ascoltiamo una notizia terribile dai fronti aperti ai confini di Israele reagiamo con il dispiacere, l’orrore; se sentiamo un commento polemico antiisraeliano in un blog televisivo o in un qualsiasi canale mediatico ci arrabbiamo, proviamo a rispondere, protestare, manifestare, esprimere solidarietà. Ma il più delle volte non ci poniamo la domanda: perché succede questo? Perché proprio a noi come popolo ebraico è riservato questo nuovo spargimento di sangue e questa campagna di demonizzazione? Che senso ha, alla luce della nostra storia e alla luce di ciò in cui ha creduto il popolo ebraico da millenni?
Vi sono diversi motivi per spiegare questa elusione della domanda. Il primo è il nostro modo di pensare che è sostanzialmente “laico”, portato a spiegare le vicende umane prima di tutto secondo una dinamica sociale e politica, che chiaramente non deve mancare, ma non è detto che debba essere esclusiva. Il secondo motivo è che la ricerca di un senso più profondo è impegnativa, sia perché è difficile trovare risposte esaurienti, sia perché spesso la risposta coinvolge le responsabilità di ogni persona che da spettatore coinvolto e arrabbiato si potrebbe trasformare in una sorta di indagato.
Per dirla in temini molto semplificati, in tutta la Bibbia, e poi nella letteratura successiva, corre un pensiero uniforme: se il popolo ebraico soffre è perché le sofferenze sono un campanello di allarme che ne denuncia comportamenti scorretti e richiama a correggere le proprie azioni.
Un intero periodo dell’anno, il suo inizio, il mese di Tishrì, è dedicato a questo tema. E quest’anno il 7 ottobre cade proprio in mezzo agli Yamim Noraim, tra Rosh hashanà e Kippùr. Ascoltiamo il suono dello shofàr, che, come spiega Rambàm in questi giorni, ha soprattutto il ruolo di una sveglia: state dormendo, svegliatevi, prendete coscienza. E il ruolo dello shofàr in questi giorni è simile a quello che svolgono determinati accadimenti nella vita. Sta suonando un campanello, da mesi.
In questo periodo ciascuno è invitato a riflettere sul suo comportamento, a riparare le azioni sbagliate, e a tornare indietro (è il significato letterale della parola teshuvà). Quale possa essere il comportamento scorretto di un singolo individuo, davanti al lungo elenco di precetti da rispettare, può essere facile dirlo. Le cose si complicano quando ci si chiede quale sia il comportamento scorretto di un intero popolo. E ancora di più si complicano quando si confrontano i comportamenti sbagliati del singolo o del gruppo con gli eventi negativi che li colpiscono; spesso ai nostri occhi c’è una sproporzione inspiegabile. Tutto questo rende difficili i ragionamenti, e discutibili le conclusioni. Si pensi ad esempio che malgrado vi siano state tante interpretazioni autorevoli sulla Shoah, dal punto di vista filosofico e religioso, nessuna appare convincente fino in fondo. E le domande prevalgono sulle risposte, che qualche volta rischiano di essere banali e divisive.
Lo stesso rischio si può correre tentando di interpretare religiosamente il 7 ottobre, come ha fatto qualcuno accusando e denunciando certi comportamenti della società israeliana. Una società della quale si apprezzano le virtù ma che non è certo una società ideale, attraversata come è da polarizzazioni, fratture e profonde incomprensioni.
Il 7 ottobre ha rafforzato in molti ebrei l’identità ebraica, il sentirsi popolo minacciato. Questo per molti ebrei lontani è già un inizio di teshuvà. Dubito però che abbia risvegliato una teshuvà più forte, singolare e collettiva. Non è facile declinare in termini attuali le rampogne dei profeti della Bibbia. Non è facile, e forse è impossibile, spiegare in termini religiosi perché certe cose sono successe e stanno succedendo, ma l’incapacità di dare una risposta non ci sottrae dal dovere di esaminare noi stessi e provare a migliorarci. Il senso diretto e immediato nel messaggio antico è che non dobbiamo solo dolerci o arrabbiarci o reagire politicamente, non siamo solo delle vittime reali o potenziali, siamo persone dotate di coscienza che ogni giorno la devono sottoporre ad esame, e che devono capire cosa va fatto sul piano personale e collettivo per migliorare noi e la società.
di Guido Salvini
A un anno dal 7 ottobre, una violenza sconvolgente in cui i civili non sono stati vittime collaterali ma volute e dirette e che sembra essere stata presto rimossa dalle coscienze, una ondata di antisemitismo ha investito buona parte del mondo occidentale. Non solo una critica politica ma una avversione combattiva e rabbiosa che sembra spinta da un odio indicibile. Lo prova il cartello “Segre agente sionista” che abbiamo visto sfilare per le vie di Milano. Lo prova il cartello “Segre agente sionista” issato dalle tifoserie Pro-Pal durante un corteo per le vie di Milano. Poche e semplici considerazioni consentirebbero di dare un giudizio razionale e non ossessivo su quello che stiamo attraversando. Eccone una decisiva per chi tifa ma conosce poco la storia.
Dal 1949, dopo la fine della prima guerra con la quale i Paesi arabi cercarono di cancellare il neonato Stato di Israele, sino al 1967, la guerra dei 6 giorni, Giordania ed Egitto ebbero la piena sovranità su Gerusalemme est, della Cisgiordania e di Gaza, cioè il cuore dello Stato palestinese. La usarono in quei 18 anni di pace per creare uno Stato palestinese? Niente affatto. Continuarono a mantenere la loro sovranità su quei territori, abitati da palestinesi con i quali rapporti furono sempre conflittuali, fino a sfociare in Giordania nel 1970 nel “Settembre nero”, un massacro di palestinesi che però non fa testo perché non ne furono responsabili gli israeliani.
È quindi di Israele interamente la colpa del fatto che non esista Stato palestinese? No, senza dimenticare che fu il leader dell’OLP Arafat e non il governo israeliano a rifiutare l’intesa che era stata quasi raggiunta nel 2000 con il vertice di Camp David che profilava nella sostanza due stati.
Nel sud del Libano si è installato Hezbollah, non solo un gruppo terroristico ma un esercito potente armato dall’Iran che si muove in modo del tutto indipendente in uno Stato ridotto all’impotenza, quasi uno stato fallito, soffocato da Hezbollah come dalle spire di un serpente. Per questo Hezbollah non ha mai subito dal governo libanese alcuna conseguenza per il fatto di attaccare da anni il paese confinante e cioè Israele. È come se in Italia vi fosse un esercito di un partito estremista schierato entro i confini del nostro paese e impegnato quotidianamente e liberamente a lanciare razzi e a colpire in vario modo i vicini, la Svizzera o l’Austria. ad esempio. È una immagine che nell’Europa civile suona assurda, in Medio Oriente ove tutto è possibile no, ma serve solo per il paragone.
Per questo e con tutto il dolore che si prova per le vittime civili, l’esercito italiano ha attaccato Hezbollah che, lo si è scoperto ora, ha costruito nel sud del Libano una rete di tunnel come Hamas a Gaza. Inevitabilmente Israele ha reagito prima che l’arsenale di Hezbollah, rifornito scientificamente dall’Iran, diventasse tanto potente e sofisticato da devastare città come Haifa e Tel Aviv.
Tutto ciò anche senza indulgere nei confronti del primo ministro Netanyahu che si appoggia ai coloni in Cisgiordania e agli ebrei ultraortodossi la cui mentalità non è molto differente da quella dei radicali islamici anche se, a differenza questi ultimi, per fortuna non intendono conquistare e soggiogare il mondo intero.
Intanto nel Sudan, a poca distanza dal teatro di guerra di Gaza, infuria da più di un anno una feroce guerra civile tra due fazioni militari, una delle quali d’ispirazione radicale islamica. Questo conflitto ha già provocato decine di migliaia di vittime, non meno che a Gaza, carestie, malattie e l’evacuazione di milioni di persone dalle loro abitazioni. Ma non se ne parla, salvo qualche organizzazione umanitaria, o quasi. Quanto sta avvenendo in quel paese non è spendibile politicamente e quindi non interessa a nessuno. Non ci sono né cortei né mobilitazioni di studenti né appelli contro il genocidio. Questo silenzio dimostra l’ipocrisia della campagna contro Israele che si gonfia ogni giorno.
Ma la guerra non è solo quella con i razzi, è anche quella delle parole perché la comunicazione è la chiave del mondo contemporaneo. Ciò che viene detto e prende la forma di una parola simbolo esiste, ciò che non ha una parola non esiste.
Nel linguaggio politico e nei mass media è di casa il termine islamofobia, usato quasi sempre a sproposito. È indubbio che gli attentati di Al Qaeda alle Torri gemelle in poi, in seguito gli eccidi compiuti anche in Europa dall’Isis, i talebani afghani e la politica dittatoriale all’interno e aggressiva all’esterno dell’Iran abbiano provocato una diffusa paura nei confronti del mondo islamico. Ma certo non un razzismo generalizzato o una volontà di distruggerlo. È un’espressione quindi inventata, una violenza linguistica, e la violenza peggiore, come insegnava Ludwig Wittgenstein, è il cattivo uso delle parole. Islamofobia è un gioco di parole che fa solo il gioco appunto delle componenti più radicali di quel mondo e consente loro di passare da vittime e di soffiare sul fuoco anche quando decine di milioni di musulmani sono cittadini, regolarmente residenti o ospitati nei paesi europei.
Piuttosto quello che sta succedendo e che di più grave potrebbe accadere dovrebbe comportare l’uso di una espressione ben diversa che però è tenuta fuori dal linguaggio: israelofobia, che non coincide con l’antisemitismo perché riguarda oggi proprio lo Stato d’Israele.
L’idea in sostanza che Israele non abbia diritto di esistere, purtroppo molto diffusa anche tra un buon numero di occidentali esaltati, nel peggiore dei casi, o sprovveduti, nel migliore dei casi che non si accorgono così di odiare anche sé stessi.
Perché non cominciare a riconoscerla e a usarla? In fondo il linguaggio è uno strumento di educazione civica e imparare ad usarlo aiuta a modificare in meglio il mondo in cui dobbiamo vivere e se possibile convivere.
di Mariano Giustino
Iran a mani nude. Storie di donne coraggiose contro ayatollah e pasdaran”: è il libro scritto da Mariano Giustino (Rubbettino, 13 euro). Corrispondente dalla Turchia di “Radio Radicale”, collabora con “Il Foglio”, “Huffington Post” e altre riviste. È vincitore del “Premiolino” 2024, il più antico e prestigioso riconoscimento italiano dedicato all’informazione. Dal libro pubblichiamo il capitolo dedicato a Narges Mohammadi, un Nobel dedicato a tutte le donne iraniane in lotta per la loro libertà.
Narges avrebbe potuto vivere con i suoi figli gemelli, Kiana e Ali, che ora vivono in Francia con suo marito, Taghi Rahmani, ma ha scelto di lottare per il futuro dei bambini e dei giovani iraniani.
Narges Mohammadi, 51 anni, attivista iraniana per i diritti umani, è stata insignita del Premio Nobel per la pace 2023, per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti i popoli dell’Iran.
L’attivista è stata arrestata ben 13 volte, sottoposta a cinque condanne per complessivi 31 anni di prigione. Ha subito indicibili torture, tra cui 154 frustate. È tuttora in prigione dal novembre 2021. Era stata arrestata per la prima volta 22 anni fa quando era una giovane studentessa di Fisica. Allora si distinse come sostenitrice dell’uguaglianza di genere e dei diritti delle donne. Nel 2011 subì una prima condanna a diversi anni di reclusione per il suo impegno nell’assistere gli attivisti incarcerati e le loro famiglie.
La Nobel per la Pace 2023 ha trascorso gran parte degli ultimi due decenni dentro e fuori dalla prigione per la sua instancabile campagna per i diritti umani nel suo paese. Dopo un primo rilascio su cauzione, Mohammadi si è immersa in una campagna contro la pena di morte. Il suo attivismo contro la forca l’ha portata, nel 2015, ad un suo nuovo arresto e a una condanna a ulteriori anni di reclusione.
La massiccia ondata di proteste, iniziata lo scorso anno, è diventata una grande speranza per le migliaia di prigionieri politici detenuti nel famigerato penitenziario di Evin a Teheran, noto come la “prigione degli uomini illustri dell’Iran”. Dal 1972, da quando fu edificato e la sua gestione passò alla polizia segreta Savak, alle dirette dipendenze dello scià, artisti, accademici, registi, scrittori, giornalisti e oppositori, sono tutti passati da Evin. Quel carcere era diventato un mito per gli oppositori della monarchia, vi furono rinchiusi gli eroi rivoluzionai che l’avevano combattuta. Fu tra i primi posti liberati dopo il crollo della dinastia Pahlavi, che aveva ideato quell’inferno. L’idea di coloro che vi avevano abitato era di trasformare il simbolo della spietatezza della monarchia iraniana in un luogo di pellegrinaggio. Invece la Repubblica islamica adottò le stesse terribili misure repressive del despota Pahlavi: torture e impiccagioni. I prigionieri liberati e portati a spalla dal popolo non sapevano che in meno di un anno sarebbero stati riportati lì, di nuovo in quel carcere, per essere fucilati o impiccati, ma questa volta dal regime teocratico.
Dalla prigione di Evin, l’assegnataria del Nobel della Pace ha contribuito con la sua lotta affinché le proteste non si placassero. La leader per i diritti umani sostiene ora che quei moti rivoluzionari scatenati dopo la barbara uccisione d Mahsa Amini, sono irreversibili e che il regime islamico ha i giorni contati.
Mohammadi non vede i suoi figli da otto anni perché ha trascorso la maggior parte della sua vita recente in prigione ed è consapevole che non c’è alcuna prospettiva immediata di un suo rilascio. Il prezzo che sta ancora pagando per il suo attivismo è incommensurabile perché ha perso gran parte dell’infanzia dei suoi figli gemelli: non ha potuto né vederli crescere né ascoltare le loro voci per le restrizioni imposte dalla prigionia che impedisce anche di avere colloqui telefonici. “La mia sofferenza più indescrivibile è non poter vedere i miei figli”, ha dichiarato in una sua recente intervista rilasciata per iscritto a France-Presse dalla prigione di Evin.
“Il prezzo che si paga non è solo quello della tortura e della prigionia, ma è quello del cuore che si spezza, è del dolore che colpisce il midollo delle ossa”, e ha aggiunto: “Finché la democrazia, l’uguaglianza e la libertà non saranno conquistate, è necessario continuare a combattere e a sacrificarsi”. Mohammadi sostiene che la società ha raggiunto una maturità tale da comportare un forte indebolimento del regime religioso-autoritario.
L’Iran ha visto anche prima del 16 settembre 2022 diversi focolai di protesta, sempre guidati dalle donne e questo dimostra la natura irreversibile di quest’ultima “rivoluzione contro l’apartheid di genere e per l’abbattimento della Repubblica islamica” e la portata dell’espansione delle sue proteste. “Ora è il momento di realizzare la democrazia”, sostiene Mohammadi.
Dopo 44 anni di oppressione, di discriminazione e di continua repressione del mostruoso regime contro le donne, sottoposte ad apartheid, c’è l’assoluta consapevolezza, soprattutto tra le giovanissime, che può esistere un mondo in cui è possibile vivere la propria libertà. Si è creato un movimento rivoluzionario spontaneo, partito dal basso, con un obiettivo ben preciso: il rovesciamento della Repubblica islamica attraverso l’abbattimento del “regime di apartheid di genere” che sta rappresentando la più seria sfida popolare ai leader teocratici del paese. A scendere nelle piazze sono i giovanissimi e a sfidare i mullah nelle strade, nei parchi e nelle metropolitane sono quelli che non hanno nulla da perdere: una generazione che rifiuta l’ipocrisia di vivere la libertà solo nello spazio privato, di una stanza della propria abitazione e la rivendica ovunque, nello spazio pubblico.
Le proteste starebbero dunque accelerando la fine della Repubblica islamica per aprire la strada a un governo democratico, basato sulla libertà e sull’uguaglianza in Iran. L’indebolimento del pilastro religioso su cui si basa il regime iraniano sta creando un vuoto che le autorità non sono in grado di riempire con altre leve come quelle economiche e sociali, poiché il sistema è essenzialmente inefficace e corrotto.
Mohammadi è sempre stata molto critica nei confronti di quelli che in Occidente non hanno adeguatamente sostenuto le forze del progresso esistenti nel paese e hanno invece perseguito politiche volte a perpetuare il regime religioso-autoritario che opprime gli iraniani. “Non ho quasi alcun prospettiva di libertà”, sostiene Mohammadi. “Ho sofferto pene indescrivibili, ma nutro ancora la speranza di vedere la luce della libertà e di ascoltare la sua voce”. La Nobel per la Pace 2023 è instancabile e in prigione, nell’ala femminile di Evin, organizza canti e balli, oltre a dar vita ad animate discussioni.
“La prigione è sempre stata al centro dell’opposizione, della resistenza e della lotta nel mio paese e incarna l’essenza della vita in tutta la sua bellezza”, sostiene Mohammadi. L’ala femminile di Evin è infatti uno dei luoghi più attivi, resistenti e gioiosi dell’orribile penitenziario, abitato dal cuore più resistente e nobile della società civile iraniana. L’attivista, ora premio Nobel, ha condiviso i numerosi anni della sua prigionia con oltre 600 donne e di ciascuna parla orgogliosamente.
L’assegnazione del Nobel per la Pace a Narges Mohammadi è arrivata proprio mentre le forze di sicurezza iraniane arrestavano la madre di Armita Geravand, la sedicenne ragazza curda in coma dal 1 ottobre 2023 dopo essere stata brutalmente picchiata dalla famigerata polizia morale in una metropolitana di Teheran. La madre di Armita è stata arrestata perché ha dichiarato di non credere alle bugie del falso rapporto presentato alla stampa dalle autorità iraniane nel quale si sostiene che la giovane donna sarebbe svenuta a causa della bassa pressione sanguigna e che per questo avrebbe battuto la testa contro una parete del vagone della metropolitana.
Subito dopo il ricovero di urgenza della ragazza, suo padre, Bahman, e sua madre, Sahin Ahmadi, sono stati letteralmente sequestrati dalle forze di sicurezza nell’intento di impedire loro di rivolgersi alla stampa e di costringerli al silenzio affinché non rivelassero alcuna informazione sull’aggressione subita dalla figlia. I genitori hanno dovuto confermare pubblicamente in TV la versione dettata dal regime, ovvero che la loro figlia non sarebbe stata vittima di alcuna aggressione da parte della polizia morale.
di Giamnarco Pondrano Altavilla
Immaginate di vivere in un Paese comunista, dove terra, risorse naturali e mezzi di produzione sono in mano dello Stato. E immaginate che qualcosa di quel Paese non vi piaccia e vi decidiate a voler scrivere un libro contro il sistema. Ingenuamente, vi presentate al burocrate incaricato di autorizzare le stampe e puntualmente il timbro rosso del rigetto cade sulla vostra pratica. Che fare? Darsi per vinti? Fortunatamente nei paraggi vive un logico che sa usare la zucca e può darvi un consiglio. E non solo di un logico qualunque si tratta, ma nientemeno che di Bertrand Russell, studioso delle sottigliezze del pensiero formale conosciuto e rispettato. «Lord Russell, cosa devo fare col mio libro?». «Vedi ragazzo mio risponde l’illustre ragionatore nulla di più semplice: questo Paese è ben organizzato. Al potere dello Stato vi sono dei contrappesi che io stesso ho elaborato. Non hai che da pagare per fartelo stampare!». E con questa perla di chiarezza venite gentilmente accompagnati alla porta. Sulle prime siete contenti perché il problema sembra risolto, ma poi vi viene di pensare: «Sì, va bene pagare, ma pagare chi se tutti i tipografi sono funzionari al soldo dello Stato che si inventeranno di tutto per evitare la rogna? E poi dove li trovo i soldi? Lo Stato? Ma se è il primo che non vuole che libro esca…».
E così, con buona pace di Lord Russell e della sua «logica» il libro finisce a reggere la proverbiale gamba del tavolo. Sembra un racconto uscito dalla penna di un maestro dell’assurdo come Lewis Carroll. Peccato che il pensiero di Bertrand Russell sul punto della configurabilità della libertà di stampa in un regime di «socialismo avanzato» fosse proprio quello e che il maestro della logica, in politica, ragionasse come il leprotto bisestile. Per chi desiderasse approfondire la questione è uscito il libro di Gaetano Pecora, Bertrand Russell tra liberalismo e socialismo (Donzelli) che mette il dito su questa e sulle molte altre piaghe dell’(il) logico Russell. Russell passa dall’incontro con Lenin che gli fa dire che: «Forse l’amore per la libertà è incompatibile con la fede assoluta in una panacea per tutti i mali» a scrivere che: «Il bolscevismo merita la gratitudine e l’ammirazione dei progressisti di tutto il mondo». Si compiace della concorrenza libero-scambista che gli fa trovare casa dopo che un primo locatore gli voleva imporre la rinuncia alle sue idee e poi si spertica per l’autogestione, che già normalmente è la soluzione per salvare la capra della libertà e i cavoli dell’anticapitalismo senza capire un accidente né di capre né di cavoli, ma che nel caso di Russell si tinge ancora di più di rosso in quanto lo Stato diventerebbe proprietario di tutto decidendo pure prezzi e livelli di produzione. Si professa scettico, ma a più riprese sembra addirittura tentare di dimostrare razionalmente i suoi valori assoluti. Insomma, un guazzabuglio che riporta alla mente una deliziosa scena di Così parlò Bellavista dove due anziane signore si recano al bancolotto per farsi interpretare i sogni e giocarsi i relativi numeri. E dopo aver segnalato che il sogno riguardava dei «bersaglieri a cavallo» si sentono rispondere dall’irato commesso che «nun’ esistono e bersaglieri a cavallo!», «E per questo è un sogno» risponde decisa una delle vecchine con mirabile logica.
Peccato che a Lord Russell difettasse un po’ di questa consecutio partenopea. Disponendone, forse si sarebbe accorto che nel campo della sua politica di bersaglieri a cavallo ne galoppavano parecchi e che i suoi sogni, alla prova dei fatti, si sarebbero rivelati incubi.