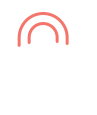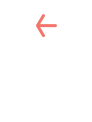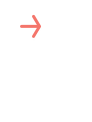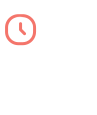di Gualtiero Donati
Una puntata di Una giornata particolare di Aldo Cazzullo dedicata a Pier Paolo Pasolini e la sua morte atroce è l’occasione per una riflessione anche sule cose dell’oggi (il delitto si consuma la notte del 2 novembre 1975). Il giorno prima Pasolini rilascia a Furio Colombo quella che sarà la sua ultima intervista. Il titolo, “Siamo tutti in pericolo” è suggerito dallo stesso Pasolini. Parla del suo “metodo”: battere sempre sullo stesso chiodo, che “può persino far crollare una casa. In piccolo un buon esempio ce lo danno i radicali, quattro gatti che arrivano a smuovere la coscienza di un paese”.
Siamo tutti in pericolo, dice Pasolini. Vorrebbe precisare meglio, ma si è fatto tardi, rimanda al giorno dopo. Quella notte però viene ucciso. Non sapremo mai come voleva precisare. Però può venire in aiuto un altro testo: l’intervento che Pasolini avrebbe dovuto tenere al Congresso del Partito Radicale due giorni dopo a Firenze. Anche quel testo forse l’avrebbe rifinito.
Strutturato in otto paragrafi, si conclude con il famoso appello ai radicali a continuare a dimenticare i successi e continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari, a pretendere, a volere, a identificarci col diverso, a scandalizzare; a bestemmiare; e continuare a essere irriconoscibili. Quest’ultima cosa è facile, visto che viene impedito in ogni modo di essere anche semplicemente conosciuti.
Tutto il testo di Pasolini merita riflessione ma un punto in particolare: quello che mette in guardia dal pericolo (torna, questo allarme, come nell’intervista a Colombo) da una nuova forma di conformismo di sinistra che si appresta ad appropriarsi della battaglia per i diritti civili “creando un contesto di falsa tolleranza e di falso laicismo…Proprio la cultura radicale dei diritti civili, della Riforma, della difesa delle minoranze sarà usata dagli intellettuali del sistema come forza terroristica, violenta e oppressiva”. Il potere, insomma, si accinge ad “assumere gli intellettuali progressisti come propri chierici”. Le date sono importanti: Pasolini lo dice nel 1975. Una previsione che si è avverata, non solo in Italia: si è affermata una nuova classe di potere totalizzante e trasformista, perfino più pericolosa delle tradizionali classi conservatrici. Testualmente, nel paragrafo settimo: “Attraverso i vostri successi, la vostra passione irregolare per la libertà, si è codificata, ha acquistato la certezza del conformismo, e addirittura (attraverso un “modello” imitato sempre dai giovani estremisti) del terrorismo e della demagogia”. E aggiunge: “So che sto dicendo delle cose gravissime. D’altra parte, era inevitabile. Se no cosa sarei venuto a fare qui?”.
Marco Pannella, Pasolini, Leonardo Sciascia: un bel guaio non avere più il conforto dei loro contributi, il consiglio delle loro critiche. Siamo davvero tutti più fragili e soli. In pericolo.
di Giovanni Maria Flick
Prendere la parola oggi mi fa sentire un po’ come tornare a casa, a quei luoghi frequentati trent’anni fa nel tentativo di promuovere una riforma del carcere. Non sempre ci siamo riusciti, e ancora oggi dobbiamo combattere per trasformarlo. Avevo preparato una traccia per parlare di volontariato in carcere e del tema del “carcere della Costituzione”. Tuttavia, mi sono reso conto che questa traccia non funziona.
Non possiamo parlare di un “carcere nella Costituzione”, perché semplicemente non esiste. Non esiste un carcere che incarni pienamente i principi costituzionali. Il carcere della Costituzione è come un’isola che non c’è: un luogo ideale, un obiettivo ancora lontano, ma essenziale per affrontare seriamente questo problema. Dobbiamo piuttosto parlare del carcere di fronte alla Costituzione o fuori da essa. Recentemente, ho riflettuto su due aspetti che mi hanno colpito.
Da un lato, le notizie che giungono dalle carceri italiani, come Trapani o Santa Maria Capua Vetere, dove emergono a ripetizione vicende di violenze e abusi che calpestano la dignità umana. Dall’altro, il libro di Papa Francesco La speranza non delude mai, che traccia un cammino verso il Giubileo, non solo come evento religioso, ma come percorso di rinnovamento della fede e della speranza.
Il Papa ci ricorda che le carceri devono diventare “laboratori di speranza”. Eppure, le nostre carceri sono ancora sovraffollate, colme di poveri e vittime di ingiustizie sistemiche. Come sottolinea il Papa, spesso il sistema penale preferisce imprigionare invece di affrontare le cause profonde della criminalità. Nonostante le parole e i tentativi di riforma, siamo ancora lontani dal garantire condizioni umane e dignitose.
Si continua a chiedere maggiore sicurezza, ma questa viene declinata come “sicurezza pubblica” nel senso tradizionale e non “sicurezza sociale”, senza un reale impegno per combattere esclusione e disuguaglianze. È più facile punire i deboli che affrontare i problemi strutturali. Un recente disegno di legge per intervenire sulla situazione drammatica del carcere, ad esempio, include disposizioni per sostenere la polizia penitenziaria, giustamente, ma introduce anche norme apparentemente scollegate, come la reintroduzione del peculato per distrazione al posto dell’abrogato delitto di abuso d’ufficio. Viene da chiedersi: ha davvero senso, in questo contesto, aggiungere un nuovo reato? È il momento di riflettere sulle vere priorità.
Il Papa ci invita a “tenere aperta la finestra della speranza”, sia per i detenuti come singoli, sia per il sistema nel suo complesso. Ma la realtà che vediamo è diversa: sovraffollamento, carceri come luoghi di esclusione sociale, mancanza di progetti di reinserimento. Non basta costruire nuove strutture: occorre cambiare il modo in cui riempiamo quelle esistenti, mettendo al centro le relazioni, la dignità, l’affettività. Occorre considerare accanto alle relazioni le altre due componenti dell’identità della persona: quella temporale (il suo passato e il suo futuro); e quella spaziale (la sua privacy e il suo spazio vitale) emblematizzate nella “ora d’aria”. Un esempio significativo è la recente sentenza della Corte costituzionale che riconosce il diritto all’affettività per i detenuti.
Questo diritto non riguarda solo i legami personali, ma tutte le relazioni che possono favorire il reinserimento sociale. Tuttavia, siamo ancora lontani da una reale trasformazione: il numero di suicidi in carcere cresce, e le risposte istituzionali restano insufficienti. Non possiamo dimenticare l’importanza del volontariato, che rappresenta quella “finestra” attraverso cui chi sta fuori può vedere e comprendere il carcere, e chi sta dentro può prepararsi al ritorno nella società.
Ricordo i miei primi passi da ministro, quando affrontai i conflitti tra volontariato e personale di custodia. Fu chiaro allora, come oggi, che senza volontari il carcere rischia di perdere quella dimensione umana indispensabile per la rieducazione e prima ancora per la sopravvivenza. Occorre promuovere la cultura in carcere: l’accesso al sapere, alla formazione, al patrimonio storico-artistico.
Non possiamo accettare logiche che negano questi diritti, come accaduto in un caso che ho seguito come avvocato alla Corte di Strasburgo. Un detenuto si era visto negare la detenzione domiciliare non solo per mancanza dei presupposti, ma con la motivazione aggiuntiva che, avendo conseguito una laurea e un master, era diventato “più pericoloso”.
Una logica aberrante, che rischia di scoraggiare ogni percorso di crescita. Il Papa ci ricorda che non c’è giustizia senza misericordia. La solidarietà, l’uguaglianza e la valorizzazione della diversità sono i principi su cui deve fondarsi il volontariato. Non si tratta solo di tamponare le carenze del sistema, ma di mediare, proporre e costruire percorsi concreti di riforma. Tuttavia, non possiamo limitarci a belle parole: abbiamo sprecato troppe occasioni, come gli “Stati generali” del carcere, che si sono persi in discussioni accademiche senza portare a veri cambiamenti.
Dobbiamo trovare un equilibrio tra sicurezza, prevenzione e rieducazione. Eliminare. Eliminare gli automatismi legislativi che ostacolano il trattamento personalizzato. Imparare dalle lezioni della pandemia, che ha messo in luce quanto sia fragile il sistema attuale. Non basta aumentare lo spazio fisico delle carceri: serve costruire un tessuto relazionale che promuova dignità e speranza.
In conclusione, il carcere deve essere un luogo dove si coltiva il futuro, non un limbo dove si soffoca la vita. La sfida è enorme, ma non possiamo permetterci di perdere la speranza. Il Giubileo può essere un’occasione per ripensare il nostro sistema penitenziario, partendo dai principi della Costituzione e dall’appello del Papa: fare del carcere un vero “laboratorio di speranza”.
(Sintesi della relazione introduttiva che il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick ha pronunciato a Regina Coeli in occasione del 55° Convegno nazionale del Seac – Coordinamento dei gruppi di volontariato penitenziari).
di Lia Levi
Ci avete chiamati. Ci avete accolti con calore nelle vostre scuole. O anche in sale istituzionali dove abbiamo incontrato partecipi cittadini. Avrete capito che sto alludendo a me ma, naturalmente, anche ai tanti ebrei della mia generazione che hanno scelto di testimoniare. Ci avete chiesto frastornati “ma perché non vi siete difesi?”. Ci avete chiesto indignati “Come è possibile che il nostro pianeta abbia permesso questa strage?”. Gli abitanti dei paesi contigui sapevano, dicevate. Sapevano di quella colossale industria della morte ad un passo da casa loro. Potevano provare a gridarlo forte.
Ammirevoli docenti hanno diviso con noi lo sforzo di far percepire tracce di quel racconto che non si può raccontare. Validi sindaci di numerose città hanno organizzato per voi viaggi nei campi dello Sterminio. Molti ragazzi ne sono usciti sconvolti, qualcuno non riusciva più a destreggiarsi in mezzo a quel tumulto di emozioni.
Sia chiaro però. Non era la trasmissione della sofferenza che volevamo riversare su voi. Ci mancherebbe! Era solo un invito a mettere in moto la conoscenza, quella che, se funziona, si trasforma in coscienza.
È appena capitata l’occasione di parlarvi del 16 ottobre (1943) data simbolo della retata di ebrei italiani per mano degli invasori tedeschi. Sono passati ottanta anni da quel sabato nero. E ora? Come è possibile? Come è possibile che sia successo ancora una volta? Un altro ottobre del tutto simile a “quell’ottobre lì”. Di nuovo porte ebraiche abbattute con violenza. E con la stessa mirata violenza strage di giovani in festa, di neonati al calore delle loro madri, di bambini e giocattoli, di anziani all’insegna di una aggrovigliata saggezza, di donne braccate come prede.
“L’irraccontabile” è riuscito a riproporsi. Non ci avremmo mai creduto. E cosa ha risposto l’opinione pubblica? Intendo dire molti tra quelli che ci domandavano “perché non vi siete difesi?”.
Ora ci siamo difesi e voi avete incominciato (o ricominciato) a odiarci.
Un attimo di raccapriccio appena appresa la notizia, questo sì, ma proprio un attimo. Subito dopo, ecco riaffiorare i “però”, e i “ma”, “insomma è Israele il vero colpevole di quanto è accaduto. Israele che non ha mai voluto prendere atto dei diritti del popolo palestinese”.
Ho detto “subito dopo” non per caso. Va ricordato che questa presa di distanza è cominciata ben prima che lo Stato ebraico desse inizio all’attacco di risposta nella striscia di Gaza. La guerra è sempre terribile e nessuno di noi, ebrei o non ebrei, riesce ad emergere dall’angoscia di fronte alle tragiche immagini di civili innocenti martoriati che scorrono davanti ai nostri occhi. Ma questa condivisione dovrebbe trovare riscontro anche dall’altra parte. Come è successo che di colpo il male del mondo sia rappresentato solo dall’israeliano o, in modo più spicciativo, dall’ebreo?
Ma come mai i predoni del 7 ottobre 2023 si vantavano al telefono con un “mamma! Ho ucciso 30 ebrei”. Ebrei, non Israeliani. La cosiddetta giustificazione politica ha mostrato il suo vero volto. Si tratta solo del classico antico odio antisemita.
Su questi particolari però l’opinione pubblica preferisce non soffermarsi. Non ci ha messo molto tempo a far sua la vecchia-nuova variante. Un altro chiarimento però. Non è andata così per tutti. Le menti pensanti, coloro che formano il loro giudizio basandosi sulla conoscenza, su studi specifici, sulla difesa dei valori democratici, hanno fatto sentire in gran numero la loro voce. Per quello che mi riguarda personalmente posso affermare, senza aver inforcato i classici occhiali rosa, che nella mia cerchia nessuno ha pensato di schierarsi coi nemici dello Stato ebraico. Ne vedevano gli errori politici, questo sì, ma anche noi ebrei li vediamo e ci ragioniamo sopra. Io parlavo di “opinione pubblica” riferendomi alle ondate che hanno invaso le piazze, le scuole, le Università, là dove si gridava “sono con Hamas” senza pensare (o forse sì) che con una piccola frase stavi aderendo al “morte agli Ebrei” unico vero obiettivo della Hamas-militanza.
Ed ecco di conseguenza gli israeliani e gli ebrei respinti dalle fiaccolate, dalla Marcia della Pace, dal manifestare contro la violenza sulle donne, mentre la Rettrice di una Università americana di fronte al quesito: “invocare il genocidio degli ebrei viola le nostre regole di condotta?” sceglie di rispondere “dipende dal contesto”. Ma allora l’attenzione che ci avevate dedicato nelle vostre aule non era autentica. Ha fatto così presto a volar via!
È volata via per correre a far parte di quel paradiso progressista (così l’ha chiamato lo scrittore israeliano Etgar Keret) dove scatta dall’alto una specie di parola d’ordine. È là che si fanno scelte tra Stati buoni e Stati malvagi. Va da sé che Israele rientra nella seconda categoria.
È per questo che mi sento di dirvi: VOI NON MERITATE IL NOSTRO DOLORE.
Il dolore è sacro. Il dolore ha bisogno di grande rispetto. Chiunque non lo percepisce nel suo senso profondo, profana e immiserisce anche la tua sofferenza. Un mi dispiace e via non ci aiuta, anzi.
Su come rapportarci quest’anno con le celebrazioni del Giorno della Memoria si sta molto discutendo in ambienti ebraici. Non è facile individuare la posizione giusta. L’ebraismo è una religione di studi, di dubbi, domande e discussioni. Il dogma non esiste. Ognuno farà la sua scelta giusta o sbagliata.
Per quello che mi riguarda sono assillata dai dubbi. È vero: ho appena espresso quel voi non meritate il nostro dolore e quindi la mia risposta dovrebbe essere di conseguenza. Invece no. Il pessimismo è un lusso che l’ebraismo non si può permettere ha scritto un Nobel della letteratura.
Non è solo questo. Nelle scuole che comunque ci attendono i ragazzi ascolteranno quello che, nei nostri limiti, cercheremo ancora di trasmettere. Forse qualcosa gli resterà dentro. Parafrasando il celebre “chi salva una vita salva il mondo” mi viene da immaginare che chi contribuisce a salvare una coscienza potrà salvare il pensare del mondo.
(da Shalom)
di Guido Salvini
Pochi lo sanno, ma è un mio ricordo giudiziario: è stata proprio la stessa squadra del Maccabi di Tel Aviv a subire per prima slogan inneggianti al genocidio. Accadde a Varese nel lontano 1979 durante la partita, di basket, con la squadra locale Emerson Varese. I tifosi varesini avevano esposto uno striscione con scritto “Hitler lo ha insegnato uccidere l’ebreo non è reato” e “Mauthausen reggia degli ebrei” e scandito slogan come “Ebrei saponette saponette”.
Quelli individuati erano stati condannati in base alla legge n. 962 del 1967 contro il genocidio e la sua apologia applicata in Italia per la prima volta. Presidente della Corte d’assise che aveva emesso la sentenza era Francesco Saverio Borrelli, allora giudice prima di diventare il Procuratore capo di Mani pulite.
Ora, dopo i fatti di Amsterdam, le gesta dei tifosi varesini, nazistoidi che avevano allora l’esclusiva dell’odio contro gli ebrei, sembrano solo squallido teppismo da stadio. E la diga eretta nel dopoguerra a difesa delle vittime dell’Olocausto non solo ad Amsterdam, la città di Anna Frank, ma in molte città europee è ormai crollata. In Olanda intorno allo stadio non c’erano solo striscioni ma ronde islamiche, i tifosi dell’Aiax in realtà non c’entrano, con motociclette e armate di mazze e di coltelli pronte a gettare ogni ebreo in un canale. In tutta Europa e anche in Italia aspettiamoci il peggio.
di Maria Antonietta Farina Coscioni
A chi non può vedere cosa viene in aiuto? Tenere insieme emozione e razionalità, fatica e passione a volte non è sempre facile. Ed è così quando ci si appunta quello che si vuole dire per pesare ogni parola. Soprattutto per non sprecarne. Non è facile anche quando a scrivere è un testimone di tutte le possibili battaglie a difesa di ogni persona fragile. Il romanzo Il buio e altri colori del giornalista e amico Alessandro Forlani, pubblicato da Manni editori, offre ai lettori la sintesi di tutte le possibili tensioni emotive e conoscitive di chi in poco tempo – diversamente dalla realtà dell’autore – perde la vista ma non la visione, non lo sguardo sulla società e sul mondo. Il libro non è un’inchiesta sociologia, è una storia, anzi sono tante storie. Nella parte dei “quattro sensi” c’è “anzitutto il tatto, il senso per eccellenza di chi non vede, situato nella pelle di tutto il corpo. Secondo la scienza serve a riconoscere la durezza e la forma del mondo esterno”. Non vale soltanto per gli ipovedenti. È vero e vale per tutti, il corpo pensa e sente quanto la mente e ci parla.
Il protagonista è Michele, un uomo di 46 anni, di professione giornalista, che si ritrova a dover ricalibrare la propria vita, reimparare a fare tante cose, la prima fra tutte confrontarsi con il limite, i limiti quali camminare, lavorare, fare la spesa, gestire la presenza pietistica degli altri.
Tra i tentativi di corteggiare una collega, le truffe di chi cerca di approfittarsi della sua fragilità, le difficoltà tecniche connesse alla professione, le complicazioni burocratiche, Michele affina altre sensibilità: gli odori, in particolare, diventano colonna sonora della sua giornata.
La vicenda, raccontata anche con molta ironia, di un uomo tenace che, con il cane Asia al suo fianco, non rinuncia alla propria autonomia e al proprio mondo: nemmeno nella metropolitana di Roma. E con il romanzo “Il buio e altri colori”, l’autore è riuscito magistralmente ad affrontare la cecità con toni a tratti dissacranti.
Nella realtà l’autore è diventato ipovedente nel tempo, è affetto da una malattia genetica quale la retinite pigmentosa; è sposato con Antonella anche lei non vedente ma dalla nascita e hanno una figlia Michela, l’unica in famiglia a vedere. Il romanzo di Alessandro Forlani ci offre la sceneggiatura di una pièce teatrale, assolutamente da non perdere.
di Matteo Lo Presti
Aveva due occhi color celeste, una testa voluminosa, su un corpo alto solo un metro e mezzo. Era parsimonioso, indossò un cappello per circa vent’anni, ma consigliava di “non presentarsi al prossimo con abiti disgustanti”. In paese regolavano gli orologi dalle abituali uscite da casa, sempre verso mezzogiorno, si addormentava avvolto in coperte come un baco da seta nel suo bozzolo. Poco capiva delle donne: una sua nobile amica, vicina alle nozze gli confessò di non essere illibata. “Devi dire tutto al tuo promesso sposo”. La ragazza seguì il consiglio, il fidanzato la ripudiò e lei dopo tre mesi si suicidò gettandosi dalla finestra. Si chiamava Emanuele Kant era nato il 22 aprile 2024 a Koeningsberg, nella Prussia orientale porto sul Baltico, oggi territorio russo e dopo il 1946 si sarebbe chiamato Kaliningrad.
Due secoli dopo le scoperte eliocentriche di Copernico e Galileo, dalla sua intelligenza scaturì un importante rivoluzione filosofica: l’uomo diventava il protagonista del viaggio che compie nei labirinti del pensiero. “Non si può fondare una metafisica (= oltre il mondo fisico) su basi razionali (cioè scientifiche)”. Dio diventa un obiettivo etico del nostro cercare, cioè, della nostra libertà. Una visione antropocentrica, prodigioso edificio fondamento della filosofia moderna. Nelle drammatiche vicende attuali il pensiero di Kant è luminoso insegnamento per tenere lontana l’ipotesi distruzione nucleare che tutti paventano.
Nella tormentata Europa del 1795 tra le paure sollevate dalla Rivoluzione Francese e i futuri esiti dell’epopea militare di Napoleone, il mite Kant pubblica un singolare libretto intitolato Per la pace perpetua. Il titolo del saggio è Kant a spiegarlo “Se quest’iscrizione satirica posta sull’insegna di un osteria olandese, nella quale era dipinto un cimitero, valga per gli uomini in generale o in particolare per i sovrani, non mai sazi di guerra, oppure valga solo per i filosofi, che vagheggiano quel dolce sogno, può lasciarsi indeciso”. Un testo di sbalorditiva attualità che, pochi, purtroppo leggono.
Kant non ha indecisioni valutative. Indica elementi per realizzare la Pace Perpetua: un presupposto repubblicano alla base della costituzione di ogni singolo stato; un presupposto internazionalistico che edifichi un’unione federale di stati desiderosi di stringere tra loro una lega della pace; il presupposto cosmopolitico, cioè la garanzia del diritto di ospitalità reciproca, con rigorosa proibizione del colonialismo. E ancora: non stringere trattati di pace che seminino germi di nuove guerre. Nessuno stato deve essere incorporato da altri e nessuno stato deve usare l’inganno interferendo negli affari interni di altro stato. E ancora abolire gli eserciti permanenti. La politica deve essere gestita in pubblico, perché ciò che viene gestito in segreto prepara arbitrio e inganno. Il diritto cosmopolita deve essere focalizzato sulle condizioni di un’universale ospitalità. Kant aggiunge con rigore di forte attualità: “Ospitalità significa il diritto di uno straniero che arriva su un territorio di un altro stato di non essere ,da questo, trattato ostilmente” come a dire teniamo lontane da noi sciocche e disumane discriminazioni.
Insomma, la preziosa tesi di Kant è che la pace richiede la subordinazione della politica alla morale. Norberto Bobbio ebbe a scrivere: “Le idee di Kant restano tra le più audaci e illuminate che mai siano state concepite sul tema. Sono anche oggi una base di discussione e un sicuro orientamento per chiunque sia convinto che il problema dell’eliminazione della guerra è diventato problema cruciale del nostro tempo. Kant aveva una concezione ottimistica della storia che oggi noi non abbiamo più”.
Era utopistico il disegno di Kant? Hegel pensava che lo fosse perché “una lega tra stati pacifici, non può avere garanzia di durata senza un potere coattivo, al di sopra delle parti, capace di fare osservare i patti”. Ma anche perché l’idealista Hegel pensava che la guerra fosse necessaria alla storia come il vento sul mare, per impedire di farlo imputridire. Kant spiega che è difficile invertire il senso della storia. Ma oggi sappiamo che questo convincimento ha necessità legate alla sopravvivenza.
Il pensiero di Kant è alla base del federalismo europeo teorizzato da nobili antifascisti rinchiusi nel carcere di Ventotene dalla dittatura di Mussolini: Altiero Spinelli, Eugenio Colorni (ucciso per strada a Roma dai fascisti), Ernesto Rossi (molti anni di confino). Personaggi a cui dobbiamo il loro “Manifesto” nel quale si formulavano auspici per una comunità europea liberale, solidale e democratica. Kant e le coraggiose riflessioni, nel bicentenario della nascita, meritano di essere accolte con ragionevole ottimismo: aveva cercato con il suo impegno critico di lasciare il mondo migliore di come lo aveva trovato.
di Michele Minorita
Con Fino a prova contraria del 1999, Clint Eastwood si schiera contro la pena di morte, o almeno contro un certo modo di applicarla: Steve Everett è un giornalista, licenziato per la sua incapacità di far compromessi con il Potere e chi lo incarna, un caratteraccio che annega nella bottiglia. Il caso lo fa incrociare con condannato a morte, per l’omicidio di una donna incinta. Lui dubita, tanto fa che riesce a cagionare il condannato.
Vent’anni arriva Richard Jewell: una guardia di sicurezza sventa un attentato durante un concerto, ma viene accusato di essere lui l’attentatore. FBI e giornali al seguito sono certi della sua colpevolezza, lo perseguitano, distruggono la sua vita, ma Jewell è innocente, alla è scagionato. Quante volte abbiamo visto, nella realtà, colpevoli certi che certamente non lo erano, vittime di intrighi e pregiudizi.
Il trittico eastwoodiano si completa con Giurato numero 2; forse l’ultimo film di questo grande cineasta, giunto ormai al suo My way. Come ogni suo film sobrio, essenziale, senza ombra di retorica: come il linguaggio della prateria: Yep o Nope. Si indovina che anche questa volta pochi sono stati i ciak: quasi sempre “buona la prima”.
Eastwood in più di un’occasione ha riconosciuto di aver contratto un debito con Sergio Leone. Certo: due stili diversi: l’italiano è maestoso, immaginifico, ha l’epopea nel sangue, Iliade e Odissea i suoi punti di riferimento: nel tempo impiegato per il prologo di C’era una volta il West un maestro come John Ford racconta metà della sua storia.
A parte le dilatazioni e i tempi, sia Eastwood che Leone “vedono” il film prima ancora di allestire la prima scena. Hanno tutto ben chiaro: immagini, espressioni, frasi, ritmi, musiche, pause, dissolvenze. Leone è fluviale; Eastwood è rarefatto, ma entrambi hanno il gusto della battuta; cinici non indifferenti, disincantati non estranei. I loro personaggi sono solitari eroi loro malgrado, fanno quello che è giusto. Non si attendono nulla, nulla chiedono.
Giurato numero 2, è anche la sintesi di esperienze e modi di “sentire” di due generazioni apparentemente lontane che si intendono benissimo: il novantaquattrenne decano dei registi americani, cantore di un’umanità che strappa la vita con le unghie e i denti; e un giovane sceneggiatore, Jonathan Abrahms, capace di distillare una storia dura e senza smancerie, in sintonia con quelle in cui si identifica Eastwood.
In sintesi: una coppia di giovani con brutte esperienze alle spalle. Lei è incinta, forse le cose si aggiustano…Lui è sorteggiato per fare il giurato in un caso di femminicidio.
Giurato numero 2 pone una questione tremendamente seria, il rapporto tra diritto e valori, quando questi ultimi cessano di essere tali, e si è disposti a ignorali, calpestarli perfino… Lo stesso Eastwood fornisce una chiave di lettura: “Guarda con attenzione alla zona grigia, a tutto ciò che accade tra il bianco e il nero della vita quotidiana. Spero che faccia scattare una domanda: che cosa fareste voi nei suoi panni?”.
La battuta cruciale: «Qualche volta la verità non è giustizia». Andrebbe scolpita nelle aule di giustizia. Altro che la “Legge è uguale per tutti”.
un appello
Ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
Nei prossimi giorni, si procederà per la prima volta alla nomina del Collegio del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità. La rilevanza delle questioni in gioco ci induce a rivolgervi con fiducia il seguente appello che porta con sé anche le parole di un giovane uomo, stroncato da una malattia neuro degenerativa ancora inguaribile.
“Ci sono malattie con le quali è possibile vivere. Altre con cui è possibile convivere. Infine, ve ne sono alcune alle quali si può sopravvivere. La sclerosi laterale amiotrofica non rientra in nessuna di queste tre categorie, è una malattia che non lascia molto spazio di manovra e che può essere affrontata soltanto sul piano della resistenza mentale… L’intelletto è l’unica risorsa che può aiutarti. Per quanto riguarda gli esempi pratici, se ne facessi uno, il lettore potrebbe apprezzarlo così come un cieco al quale è stato chiesto cosa prova nel vedere un tramonto”.
Sono le parole di Luca Coscioni morto di SLA nel 2006 a soli 38 anni.
La candidatura che noi sosteniamo è quella di Maria Antonietta Farina Coscioni impegnata da più di un quarto di secolo a favore della “liberazione” del malato e del disabile da ogni forma di discriminazione, emarginazione, o restrizione dei suoi diritti umani, civili e politici. Perché, come lei sostiene, per le fragilità fisiche e psichiche, le malattie e le disabilità, non esistono “comfort zone”; ci sono storie e vite sulle quali il rischio che cada il silenzio – della ipocrisia, della indifferenza e del pregiudizio – è sempre in agguato.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è una nuova, importante figura istituita in attuazione della delega conferita al Governo. Si attua quanto previsto dall’articolo 33 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, per la quale Maria Antonietta Farina Coscioni, da parlamentare, nel 2008 ha presentato la relativa proposta di ratifica.
Sappiamo che si è battuta per l’affermazione del diritto di voto a domicilio dei disabili intrasportabili; ha fatto parte, come membro esperto, del tavolo tecnico della Commissione ministeriale sulla SLA; con Luca Coscioni, suo marito, ha vissuto l’esperienza totalizzante della SLA; con lui ha trasformato la malattia progressiva e invalidante in battaglia politica per la dignità della vita, la libertà di cura e terapia, per la libertà di ricerca scientifica.
La disabilità non è solo quella fisica, che paradossalmente potrebbe essere perfino più “semplice” da trattare, e con la quale “trattare”. C’è quella psichica: un terreno tortuoso, perché non sempre riconosciuta. Laddove lo è, spesso viene ritenuta “pericolosa” e sfocia in nuove forme di ghettizzazione. Maria Antonietta Farina Coscioni ha “viaggiato” all’interno degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) prima della loro chiusura; oggi, con l’istituto Luca Coscioni che presiede, all’interno delle REMS.
Si tratta ora di nominare i membri che costituiranno il collegio del Garante dei diritti delle persone con disabilità. Si richiede che siano in possesso “di notoria indipendenza, specifica comprovata professionalità, comprovata conoscenza competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità”. Riteniamo che Maria Antonietta Farina Coscioni abbia tutti i requisiti per ricoprire questo delicato e impegnativo ruolo. Per questo ne promuoviamo e sosteniamo la candidatura”.
Carlo Verdone, regista, attore; Massimo Barra, presidente emerito di CRI, fondatore di Villa Maraini; Clemente Mimun, direttore TG5; Gianluigi Nuzzi, giornalista, saggista; Gianluca Nicoletti, giornalista, conduttore Melog Radio24; Stefano “Elio” Belisari, musicista, fondatore “Elio e le Storie Tese”; Rocco Tanica (Sergio Conforti), compositore, autore televisivo; Fondazione Cervelli Ribelli; Associazione “Articolo21”; Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin; Associazione “Leali delle Notizie”; Blind International Orchestra; Gianfranco Pannone, regista; Carmen Lasorella, giornalista; Giacomo Ebner, giudice tribunale di Roma; Mario Sabatelli, neurologo Università Cattolica, Gemelli di Roma; Zena Orunesu, avvocato, foro di Sassari; Fulvio Abbate, scrittore, giornalista; Giovanni Cupidi, vice presidente associazione “Siamo Handicappati No Cretini”; Padre Ubaldo, sacerdote cappuccino, biblista, docente emerito Istituto teologico “San Pietro” di Viterbo; Lamberto Maffei, già presidente Accademia dei Lincei, professore emerito alla Scuola Normale di Pisa; Ester Di Napoli, avvocato, esperta nel settore dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; Elisa Marincola, portavoce associazione Articolo21, tra i fondatori del Premio Morrione; Antonio Pascale, scrittore, saggista, autore teatrale e televisivo; Maria Amelia Monti, attrice; Luca Perrino, presidente associazione “Leali delle Notizie”; Giovanni Gifuni, presidente del Premio “Giambattista Gifuni”; Carla Rossi, professore Statistica Medica, Università di Roma Tor Vergata; Veronica Femminino, giornalista; Pompeo Martelli, direttore del Museo Laboratorio della Mente; Salvo Toscano, scrittore, giornalista TGR Sicilia; Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene e Medicina preventiva, Università di Pisa; Roberto Caminiti, professore di Fisiologia e farmacologia, Università La Sapienza; Alessandro Barbano, giornalista; Carlo Romeo, giornalista, già dirigente RAI; Domenico Iannacone, regista, autore televisivo e teatrale; Christian Mario Angeli, regista teatrale e cinematografico; Elsa Di Gati, giornalista RAI; Franco Scarpa, direttore sanitario OPG (ex) Montelupo Fiorentino; Sara Delmonte, psichiatra, direttore REMS Reggio Emilia; Claudio Rizza, giornalista; Stefano Vaccara, giornalista; Giuseppe Nicolò, psichiatra, direttore DSM ASL Roma5 e REMS Subiaco e Palombara Sabina; Gianfranco Rivellini, psichiatra, direttore REMS Veneto Nogara; Giuseppe Ducci, psichiatra, direttore DSM ASL Roma1; Manoocher Deghati, fotoreporter; Mauro Biani, illustratore di Repubblica; Carlo Fusi, giornalista; Alfredo Santoloci, direttore d’orchestra, già direttore Conservatorio Santa Cecilia; Giuseppe Giulietti, presidente della FNSI; Giuseppe Martino Di Giuda, vicedirettore Università di Torino; Stefano Corradino, giornalista RaiNews24; Michele Chiodarelli, segretario Federazione MN Psi; Giorgio Santelli, giornalista RaiNews24; Gianfranco Schiavone, presidente Consorzio italiano di Solidarietà; Timoty Dissegna, direttore de Il Goriziano; Eleonora de Nardis, giornalista RAI; Emanuela Bonchino, giornalista RaiNews24; Giuseppe Paciolla e Anna Motta, genitori di Mario Paciolla; Enzo D’Antona, presidente Teatro Miela di Trieste; Carlo Muscatello, presidente AssoStampa; Daniela Schifani Luchetta, presidente Fondazione Luchetta; Graziella Di Mambro, giornalista; Claudio Cattaruzza, imprenditore; Nicole Corritore, OBC Transeuropa /CCI; Riccardo Noury, scrittore; Gioia Meloni, giornalista; Barbara Schiavulli, giornalista, direttrice di Radio Bullets; Cristiana Ruggeri*, giornalista Rai; Giuliana Pittalis Chessa, insegnante, assessore alla Cultura Comune di Orune (NU); Giovanna Reanda, direttore di Radio Radicale; Valter Vecellio, giornalista, direttore di Proposta Radicale; Alessio Falconio, già direttore di Radio Radicale; Maurizio Turco, presidente Fondazione Marco Pannella; Francesca De Carolis, giornalista, scrittrice; Giancarlo Governi, scrittore e autore; Alessandro Forlani, autore, giornalista Radio1 RAI; Matteo Collura, scrittore; Pietro Basoccu, medico e fotografo; Filippo Ceccarelli, giornalista; Marco Milia, professor Liceo artistico Ripetta di Roma, scultore; Paola Severini Melograni, giornalista, saggista; Gianluca Abbate, Osservatorio di diritto del Terzo Settore; Maria Cristina Polidoro, ingegnere; Susanna Conti, già dirigente di Ricerca Epidemiologa dell’Istituto Superiore di Sanità; Gianluca Foresi, attore, regista; Monica Maria Caterina Cossu, ordinario di diritto commerciale, UNISS; Michele Passione, avvocato, foro di Firenze; Maurizio Doro, imprenditore; Giovanna Obinu, avvocato, foro di Nuoro; Martino Loddo, dirigente MEF; Emanuele Pisano, avvocato, foro di Cagliari; Maurizio Serra, avvocato foro di Sassari; Giuseppe Bandinu, avvocato foro di Roma; Maria Lorena Orunesu, agronoma; Antonella Orunesu, medico; Paola Serra, avvocato foro di Sassari; Gianfranca Nieddu, psichiatra; Iva Boldrini, pittrice, fotografa; Pierluigi Battista, scrittore, giornalista; Gianfranco Brundu; Daniele Sanna; Alberto Satta; Lucia Stara; Gianluca d’Amelio; Antonio Gana; Francesco Brundu; Aurora Sanna; Francesca Passino; Silvia Mureddu; Marcello Caddori; Maddalena Boe; Attilio Cherchi; Antonio De Giorgi; Maria Francesca Fantato; Antonella Canu; Piero Sanna; Maria Manca; Annunziata (nota Nunzia) Burrai; Antonello Soru; Vittorio Melone, avvocato foro di Vasto; Domenica Obinu; Antonio De Michele; Elisabetta Fanari; Lucia Lubinu; Pietro Capitata.