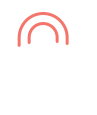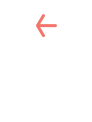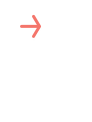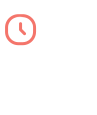Perché una commissione parlamentare sulle morti per suicidio in carcere
di Maria Antonietta Farina Coscioni
In carcere ci si uccide, il carcere uccide. Suicidi e suicidati. Inequivocabili cifre lo confermano: nel 2012 i detenuti suicidi sono stati 56; 42 nel 2013; 44 nel 2014; 39 nel 2015; 39 nel 2016; 48 nel 2017; 62 nel 2018; 54 nel 2019; 62 nel 2020; 58 nel 2021; 85 nel 2022; 70 nel 2023. Una novantina nel 2024.
Dal 2018 il numero dei detenuti suicidi non è mai sceso sotto i cinquanta. Questo senza considerare i tentati suicidi sventati da compagni di cella o dal personale della comunità penitenziaria; gli atti di autolesionismo; non vanno inoltre ignorati i suicidi tra gli stessi agenti della polizia penitenziaria.
Questa è la “fotografia” della situazione che si concretizza da anni.
Ogni suicidio costituisce una storia a sé. Molteplici e diverse sono le motivazioni che possono spingere una persona a togliersi la vita. Un fatto, tuttavia, è indiscutibile: nel momento in cui lo Stato priva un cittadino della sua libertà e ne è custode, automaticamente si rende responsabile della sua salute fisica e psichica. Non solo. Non impedire un evento quando si ha l’obbligo di impedirlo e prevenirlo, equivale a cagionarlo. I detenuti presentano con estrema frequenza alti livelli di sofferenza psicologica patologica e non solo perché la detenzione è di per sé afflittiva. La soglia della rilevazione del dolore è un obbligo dello Stato che detiene il cittadino. Il detenuto ha diritto alla conservazione del suo stato di salute, al monitoraggio sulla compatibilità dello stato di detenzione con il suo stato di salute e alla prevenzione di possibili patologie, se contratte durante la detenzione stessa. È onere dello Stato restituire alla società, una persona alla libertà sana e non malata; quindi, è obbligo la rilevazione della soglia del dolore per ogni persona detenuta.
Dunque, per ognuno dei detenuti suicidi esiste, e va accertata, una precisa, specifica responsabilità oppure esclusa. Manca tuttavia un’indagine che vada al di là del mero, clamoroso dato di cronaca, della sola indignazione post mortem, un’indagine che approfondisca le ragioni, il contesto che portano un detenuto a togliersi la vita, perfino quando mancano pochi giorni alla sua scarcerazione. Ricostruire la storia di ciascun suicida in ambito penitenziario, dal momento dell’ingresso vivo in carcere alla autopsia sul corpo. Perché gli istituti di pena hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, tutelando la vita, l’incolumità fisica e psichica degli stessi. Una commissione che possa indagare, per accertare quello che si è fatto, cosa non si è fatto, per responsabilità di chi. Centrale sarà il ruolo svolto dalla Commissione nella costruzione storica del “suicida”.
Molte morti sono inizialmente rubricate con la generica dicitura: “decesso da accertare”. Occorre conoscere le cause che hanno provocato il decesso: se sia dovuto a malattia (quale), se questa malattia sia stata adeguatamente curata (se no, per quale motivo).
Per questo motivo la Commissione deve poter accedere a tutte le cartelle cliniche dei detenuti che sono deceduti, per suicidio o altro motivo. Deve poter conoscere i risultati a cui sono giunte le autopsie, e se queste non sono state effettuate, per quale motivo non le si è fatte. La commissione parlamentare deve poter disporre dei fascicoli sanitari dei detenuti suicidi (e, nei limiti del possibile, anche di quanti non sono riusciti nel loro proposito pur avendo tentato di farlo).
Vanno ascoltate le famiglie dei detenuti suicidi, raccogliere le loro testimonianze: se erano a conoscenza del disagio psico-fisico del loro congiunto; se lo avevano denunciato e a chi; quali risposte (o silenzi) avevano accolto le segnalazioni fatte; se nel periodo della detenzione del congiunto avevano avuto segnali premonitori di quello che poi sarebbe accaduto. Come è stata loro comunicata la notizia del decesso.
Avendo come stella polare le numerose sentenze delle corti di giustizia europee, oltre alla normativa italiana, e con particolare riguardo al “Piano Nazionale di Prevenzione Suicidiaria” occorre accertare in che modo dette disposizioni sono state applicate; in caso contrario per responsabilità di chi non lo sono state.
La commissione deve predisporre una sorta di “sportello” a cui i detenuti e le loro famiglie possano inoltrare le loro istanze, con ovviamente con tutte le garanzie di riservatezza. Le istanze verranno esaminate dalla commissione che in questo modo da una parte disporrà di un utile strumento di conoscenza delle situazioni all’interno delle carceri; dall’altra, potrà intervenire nei modi che riterrà opportuni e necessari.
Analogo accertamento e modalità di inchiesta deve riguardare la situazione degli agenti della polizia penitenziaria e in generale l’intera comunità penitenziaria.